Mattioli: Il mecenate che collaborò per senso del dovere
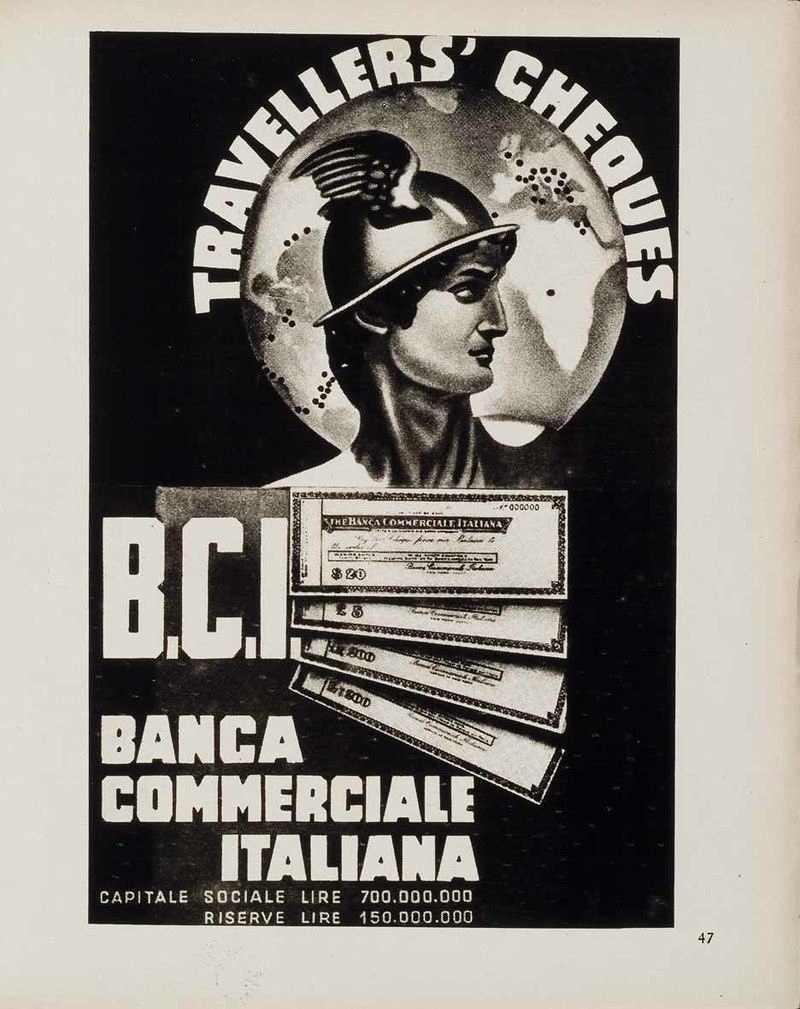

Di Nicolò Corradini
Raffaele Mattioli rappresenta, senza dubbio, uno degli archetipi della migliore classe dirigente che il nostro Paese abbia avuto. Non era un politico, nonostante avesse un'altissima considerazione del suo impegno civile e delle sue responsabilità, ma un uomo di banca, preciso e scrupoloso. Nato a Vasto, in Abruzzo, il 20 marzo 1895, dopo il diploma all'istituto commerciale si arruolò volontario nella Grande Guerra e, alla fine del conflitto, scelse di seguire D'Annunzio a Fiume, senza arruolarsi, ma come semplice osservatore, ispirato dalla retorica del Vate. Fu poi richiamato agli studi dal suo maestro, l'economista Attilio Cabiati, che lo indirizzò verso i classici del pensiero economico. In seguito fu assunto alla Camera di Commercio di Milano dove, nel 1923, redasse un schema di riforma della borsa che fu letto da Leo Goldshied, allora responsabile dell'Ufficio titoli della Banca Commerciale, il quale lo raccomandò al presidente, Giuseppe Toeplitz.
Fu così che nel 1925, all'età di trent'anni, Mattioli divenne segretario del dominus della Comit, uno dei più importanti istituti di credito dell'Italia di allora. Collaborando con Toeplitz, Mattioli ebbe l'onere e l'onore di gestire la trattativa per il salvataggio della banca operato dal regime fascista negli anni Trenta. Proprio lui, progressista e antifascista, collaborò con le migliori menti del regime mussoliniano per fronteggiare il disastro economico causato dalla crisi del 1929: l'11 settembre 1931 presentò al duce il memoriale Per la regolamentazione dell'economia italiana, nel quale proponeva di affidare i pacchetti azionari posseduti dalle banche miste e il coordinamento della politica industriale ad un ente di natura tecnica, che diverrà poi l'Istituto per la Ricostruzione industriale (IRI), creato nel gennaio 1933 e guidato da Alberto Beneduce. Il 1933 fu anche l'anno in cui il consiglio di amministrazione della Comit decise il pensionamento di Toeplitz, di cui Mattioli divenne successore all'età di trentotto anni, sebbene affiancato da Michelangelo Facconi, più vecchio di lui e che fu uno dei soci fondatori della Commerciale nel 1894. Nel 1936, inoltre, Mattioli partecipò attivamente all'elaborazione della riforma bancaria promossa da Donato Menichella, che limitava al credito ordinario gli istituti bancari e vietava loro di esporsi sui mercati azionari, detenendo partecipazioni industriali.
Parallelamente alla perizia nel calcolo e nell'analisi economica, Mattioli andava anche coltivando raffinati interessi umanistici, che gli faranno in seguito guadagnare l'appellativo di mecenate: tra il 1929 e il 1933 acquisì e sostenne il mensile letterario Cultura, diretto da Cesare De Lollis, e nel 1938 fondò la casa editrice Ricciardi. Proprio Cultura, unitamente al logo dello struzzo e al suo motto Spiritus durissima coquit, passò alla nascente casa editrice Einaudi, fondata da Giulio Einaudi, figlio del grande economista Luigi.
Essendo politicamente agli antipodi del fascismo, ospitò in casa sua e nella sede milanese della Comit i principali intellettuali antifascisti di estrazione liberale e progressista, tra cui Ugo La Malfa, Giovanni Malagodi e Adolfo Tino, che daranno poi vita al Partito d'Azione. Inoltre, pagò di tasca propria le cure a Gramsci e, quando morì il leader comunista, si adoperò per nascondere nella cassaforte del suo ufficio i fogli dei suoi Quaderni.
Caduto il fascismo il 25 luglio 1943, si trasferì a Roma, dove collaborò con i governi provvisori espressione del CLN, fino a partecipare, nel novembre 1944, ad una delegazione inviata a Washington dal governo Bonomi per chiedere appoggi politici ed economici. A questa "missione" partecipò insieme ad illustri esponenti del mondo politico ed economico, come Quinto Quintieri, ex ministro delle Finanze del governo Badoglio, Mario Morelli, futuro segretario generale della Confindustria, ed Egidio Ortona, che sarà poi nominato ambasciatore negli Stati Uniti. Fermamente repubblicano, dopo il referendum del 2 giugno rinunciò a qualsiasi incarico politico che gli fosse proposto, rimanendo saldamente alla guida della Banca Commerciale. In questo senso, non va dimenticato che, nella sua visione del bene collettivo, Mattioli intendeva per "classe dirigente" il concorso di tutti coloro che, in politica o fuori di essa, nel lavoro più
squisitamente manuale o per meriti intellettuali, amministrano e reggono "gli affari" di un Paese. Il profondissimo senso dello Stato e di giustizia, però, non lo dissuase mai da vigorose prese di posizione nei confronti della Banca d'Italia e della politica, quando si trattò di ottenere gli aumenti di capitale che sarebbero serviti per l'attività di credito. Consapevole della necessità del finanziamento industriale, lui che negli anni Venti era stato tra i primi a denunciare la scandalosa "fratellanza siamese" tra banca e industria, fu tra i promotori della creazione di Mediobanca nel 1946. Il nuovo istituto recava surrettiziamente una clausola che stabiliva la possibilità per le banche di acquistare e vendere titoli in Borsa.
Nel 1972, all'età di settantasette anni, non senza molteplici pressioni politiche, Mattioli fu estromesso dalla presidenza della Comit. Si spegnerà a Roma il 27 luglio 1973. Di un uomo simile, come di molti altri della sua generazione, che fossero a lui politicamente affini o avversi, rimane una testimonianza di serietà, di coerenza e di senso dello Stato che speriamo, come Italiani, di poter ritrovare il prima possibile.
